Durante i cambi generazionali c’è sempre una grossa fetta di utenza che specula sulle specifiche tecniche dei nuovi hardware e sui potenziali risultati, sfociando spesso in una guerra ideologica basata sui numeri che non porta a nulla di produttivo.
Purtroppo, in un contesto sociale ormai polarizzato, l’estremizzazione di un pensiero (dal più complesso al più frivolo) genera automaticamente anche l’estremizzazione di un pensiero opposto.
Di conseguenza, all’alba di un rinnovamento hardware, c’è sempre chi ci ricorda quanto in realtà sia inutile la grafica e quanto invece siano importanti il gameplay e/o la narrativa.
Ma hanno ragione? La grafica è davvero irrilevante ai fini del videogioco? La verità sta nel mezzo, come sempre.

Indice
Grafica nei videogiochi: quanto è importante?
Grafica è estetica…
Cuphead è un gioco quasi interamente disegnato a mano. Il team artistico alle spalle del progetto ha adottato lo stile unico e inconfondibile dei cartoni animati anni ’30, dopo aver accantonato altri stili meno adatti alla produzione.
Data la natura rétro del progetto, pensato attorno alle meccaniche classiche dei run’n gun, l’animazione digitale non sarebbe stata sufficiente per riprodurre perfettamente un’estetica così meticolosa, solo con il disegno manuale si è riusciti a creare immagini piene di vita e di movimento, ricalcando anche le tecniche adoperate dai disegnatori del secolo scorso.
Cuphead è un chiaro esempio di quanto la grafica, intesa come estetica, sia importante ai fini dell’identità di un videogioco, e di come possa abbracciare armoniosamente le meccaniche coinvolte.
Ma nella storia è pieno di esempi estetici particolari dove la grafica non è solo ciò che si vede, ma diventa quasi un marchio di fabbrica della saga in questione o ancor più del suo autore.
Tra tutti spiccano le produzioni di Fumito Ueda, con il loro stile minimale e riconoscibile già alla prima occhiata. ICO, Shadow of the colossus, The Last Guardian sono la rappresentazione della passione dell’autore di videogiochi verso l’arte moderna e astratta.
Quando si parla di grafica non si fa riferimento solo ai tanto odiati tecnicismi, ma anche alla componente artistico-visiva di un gioco. Non è però di questo che si lamentano i videogiocatori.
Parlare di pixel art non provoca mai scontento, anzi, in troppi sottolineano la bellezza delle produzioni meno ingorde di risorse, demonizzando invece la grafica intesa come futili tecnicismi.
I tecnicismi però non sono affatto futili.

Tornando a Ueda e prendendo come riferimento il suo The Last Guardian, possiamo ritrovarvi tutta la sua carica artistica, quell’identità forte delle sue opere, ma non possiamo ignorare l’importanza dell’engine grafico ai fini dei risultati ottenuti.
La cura con cui sono stati ricostruiti gli ambienti, ispirati ed evocativi, è nulla in confronto alla gestione delle animazioni di Trico e alla riproduzione del suo piumaggio.
Ogni piuma sul corpo dell’animale sembra proiettare una sua ombra, muovendosi indipendentemente dalle altre a seconda delle movenze o del vento.
Osservare Trico durante i suoi spostamenti è di per sé affascinante e ipnotizzante, è la massima rappresentazione della cura estetica di Ueda per le sue creature, ma è tale anche grazie a quei tecnicismi in background che hanno permesso all’animale di essere così dannatamente dettagliato e curato sin nei minimi particolari, tra cui le animazioni.
Senza quella fluidità di movimento, per altro adattiva a seconda dell’ambiente circostante, Trico non sarebbe mai apparso così vero e così vivo agli occhi degli utenti.
Demonizzare la tecnica e non l’estetica implica il non comprendere quanto siano legate assieme da un filo invisibile. Basti pensare all’iconico cappello rosso di Super Mario, figlio di necessità tecniche, in un contesto dove renderizzare i capelli in movimento durante i salti sarebbe stato un grosso investimento di risorse.
Esistono però ulteriori esempi, anche più significativi, come il rivoluzionario Jet Set Radio. Titolo che ha portato alla luce la tecnica ormai diffusissima del Cell Shading. Una soluzione che permetteva di ricreare ambienti molto saturi e dai contorni fumettosi, una soluzione che ha generato una lunga lista di opere che ne hanno tratto giovamento, come Okami o il recente e bellissimo Sea of Thives.
Parliamo pur sempre di una soluzione di rendering, quella robaccia tecnica sui cui sputare veleno, eppure quel mare blu acceso di The Legend of Zelda: The Wind Waker non lo dimenticheremo mai.

Grafica è immersione…
I virtuosismi tecnici, la mole poligonale, la complessità e qualità delle textures, gli shaders, la global illumination vengono sempre interpretati come il male assoluto da parte di un’utenza che non ne comprende affatto la reale funzione.
Si tratta di quegli strumenti che permettono ai creatori di ricostruire la loro visione, di trasformare in immagini interattive ciò che inizialmente è solo nelle loro teste.
Più potenza a disposizione, più versatilità, più poligoni, textures e illuminazione migliori permettono loro di costruire un mondo virtuale il più vicino possibile a quello immaginato.
Questo principio trasforma il virtuosismo tecnico in un elemento artistico, atto a coinvolgere il giocatore in un’esperienza audio-visiva in grado di immergerlo completamente nel contesto virtuale ricreato.
Alcuni titoli, pensati per essere più realistici di altri, sfruttando le moderne tecniche grafiche, possono trasmettere la sensazione di trovarsi davvero in quel preciso contesto, vedi i simulatori di guida come Gran Turismo o Forza Motorsport.
Il fotorealismo in questi casi non è solo un obiettivo tecnico, non è fine a se stesso, perché rientra tra le necessità del gioco. Le tecnologie e soluzioni grafiche che permettono agli sviluppatori di ottenere un effetto fotorealistico sono dunque necessarie allo sviluppo di questa precisa tipologia di prodotti, per garantire il giusto grado di immersione.

Nella storia ci sono prodotti che fanno del coinvolgimento sensoriale un cavallo di battaglia, un pilastro portante dell’esperienza che vogliono offrire.
Tra tutti spiccano senza dubbio Shenmue, gioco Sega del 1999, e i più recenti prodotti Rockstar. Titoli che vivono della loro grafica, letteralmente.
Quando Yu Suzuki ha pensato di sviluppare Shenmue, il suo obiettivo era quello di costruire un mondo virtuale che trasmettesse la sensazione di essere davvero vivo, concreto, plausibile.
Un obiettivo autoriale prima che tecnico, molto ambizioso però e che necessitava delle giuste tecnologie per poter essere concretizzato.
L’uscita del Dreamcast, ultima console della grande S e prima della generazione a 128 bit, permise a Yu Suzuki e al suo team AM2 di costruire un mondo che non si era mai visto prima.
La potenza hardware della console fu adoperata per ricostruire maniacalmente un’intera cittadina giapponese, riempiendola poi di personaggi non giocanti tutti diversi uno dall’altro.
Ognuno con un volto riconoscibile, per mezzo di diversi connotati, imperfezioni delle pelle, acconciatura, abbigliamento; ognuno doppiato con voci diverse e tutti animati da singole e specifiche routine comportamentali. Non un solo clone.
Il mondo di Shenmue, reso possibile dalle più avanzate tecnologie e da particolari virtuosismi tecnici, immergeva il giocatore in una realtà parallela alzando esponenzialmente l’asticella della potenza emotiva del medium, senza contare che la possibilità di riconoscere uno per uno tutti gli NPC si legava anche alle meccaniche e all’incedere narrativo, in quanto la componente investigativa si ramificava attorno all’interazione diretta con ciascuno degli individui presenti a Yokosuka, ognuno pronto ad aiutare a modo suo il protagonista, fornendogli informazioni utili per il proseguo delle vicende.
Un punto di rottura per il videogioco stesso, anche e soprattutto grazie alla sua grafica.

Lo stesso può dirsi per gli open world firmati Rockstar. Red Dead Redemption 2 senza quella impressionante plausibilità scenica, senza quella cura per ogni singolo dettaglio, senza quel motore grafico spremuto sino all’eccesso, probabilmente non riuscirebbe a trasmettere le stesse identiche emozioni, perché il grado di immersione in quel mondo virtuale sarebbe ridimensionato.
Ma non è tutto, l’importanza della grafica va ancora oltre, e i giocatori che ne sminuiscono il ruolo sono molto distanti dalla vera comprensione del medium videoludico.

Grafica è GAME DESIGN…
Chi si ricorda di Splinter Cell? Gioco stealth firmato Ubisoft. La sua core feature risiedeva nella possibilità di interagire con le luci per potersi occultare.
Le ombre proiettate potevano indicarci la posizione dei nemici (soluzione già adottata in precedenza da Metal Gear Solid 2), nonché i loro spostamenti, e al giocatore era permesso di pianificare una strategia giocando con l’illuminazione.
Alla base del gameplay di Splinter Cell vi era di fatto un elemento tecnico, un algoritmo nuovo, una soluzione di game design basata sull’implementazione di specifiche tecnologie legate a illuminazione e ombreggiatura.
Gli sviluppatori hanno di fatto costruito un intero gioco a partire da un principio tecnico, a partire da una tecnologia, quella cosa brutta e cattiva che non conta quanto il gameplay. Peccato che in questo caso, tale tecnologia, sia il gameplay stesso.
Cosa rimarrebbe della core-features di Splinter Cell senza quella specifica gestione di luci e ombre?

Ma si possono fare un’infinità di esempi in merito, di ogni tipo e per ogni gioco. In Metal Gear Solid V abbiamo tempeste di sabbia casuali, sottolineo la loro natura imprevedibile, che obbligano il giocatore a cambiare approccio, in quanto comportano una serie di bonus-malus legati alla distanza di visione.
In Sea of Thieves abbiamo tempeste tropicali che increspano il mare, generando onde alte svariati metri, che, unite al vento forte, portano la nave fuori rotta generando una variante di gameplay che può essere anche adoperata per sfuggire all’assalto di un’altra nave.
Il mare del gioco Rare è senza dubbio un orpello tecnico, frutto di una tecnologia che simula il comportamento dei liquidi, ma diventa gameplay nel momento in cui il giocatore decide di vestire i panni del pirata.
Non è solo dunque espressione artistica, non è solo dunque un elemento atto a trascinare l’utente in un contesto, è anche game design. Questo è la grafica.

Grafica è Videogioco…
Per i motivi espressi sopra, la grafica è da sempre uno degli elementi più importanti quando parliamo di videogiochi.
Non è certo una tendenza moderna quella di diffondere tecnicismi o analizzare nuove tecnologie, avviene fin da sempre.
La memoria corta dei videogiocatori non aiuta, ciò che loro ormai ritengono vetusto è stato a suo tempo il massimo che la tecnologia potesse offrire, basti pensare a Final Fantasy VII, Donkey Kong, Unreal, Zelda Ocarina of Time, Gran Turismo, Virtua Fighter, al vecchissimo Prince of Persia, ecc ecc.

Questo non vuol dire che per potersi emozionare sia necessario disporre delle tecnologie più recenti, la pixel art, i titoli low budget come To the Moon possono esportare un’imponente carica emotiva e riescono a farlo a fronte di semplici dialoghi o di fumetti, in quanto le limitazioni dei loro engine rendono impossibile trasmettere le emozioni per mezzo delle espressioni facciali.
Ciò nonostante esistono tanti modi per affrontare le stesse tematiche e non dobbiamo mai sottovalutare la potenza del linguaggio visivo, perché si esprime con una forza inapplicabile alle sole parole, trasformando il semplice testo in una esperienza simulata. (citazione tratta dal video di Luca Wright – Grafica è… Game Design).
Quel che viene perpetuato tra i videogiocatori, dunque, altro non è che un luogo comune sbagliato. Demagogia in salsa videoludica. “La Grafica non conta niente” è quanto di più errato si possa pensare.
Il medium videoludico è espressione artistica, è prodotto di mass market, ma è anche un software, che si lega alla tecnologia che lo ospita. Ed è per mezzo di quella tecnologia che poi si esprime.

Articoli Correlati
 Lista dei doppiatori italiani della serie di Cuphead
Lista dei doppiatori italiani della serie di Cuphead Day of the Devs: tutti gli annunci dello showcase dei giochi indie
Day of the Devs: tutti gli annunci dello showcase dei giochi indie Intervista a Stefano Brusa: doppiatore di Cuphead
Intervista a Stefano Brusa: doppiatore di Cuphead


 Red Dead Redemption II
Red Dead Redemption II
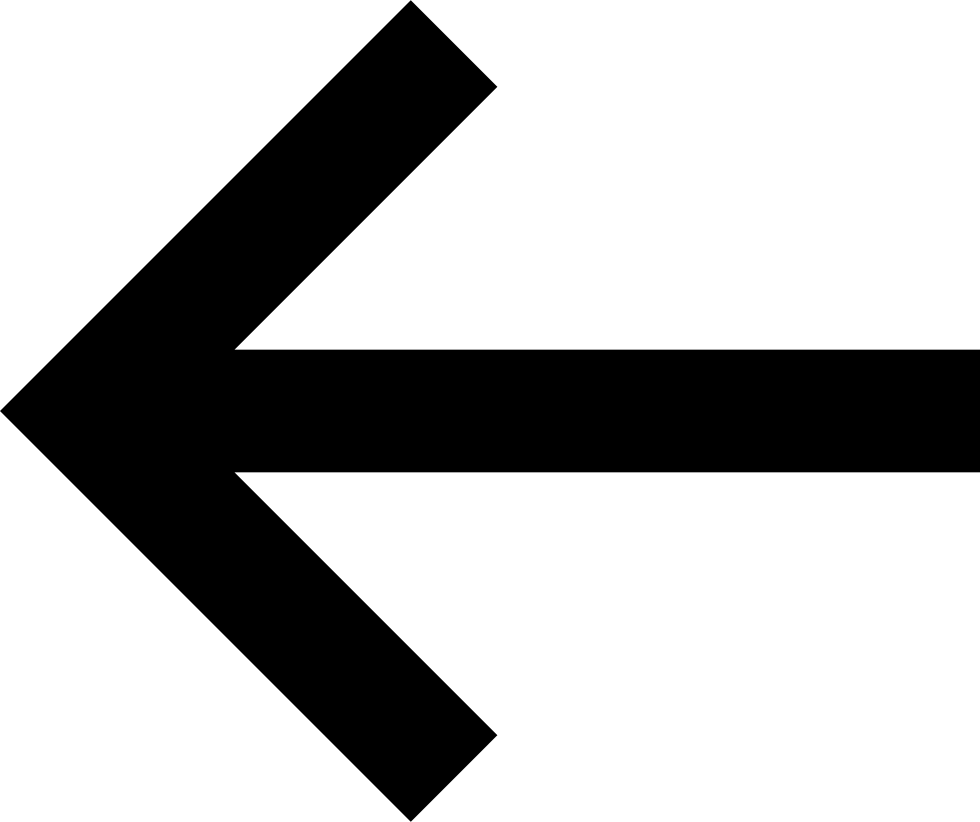
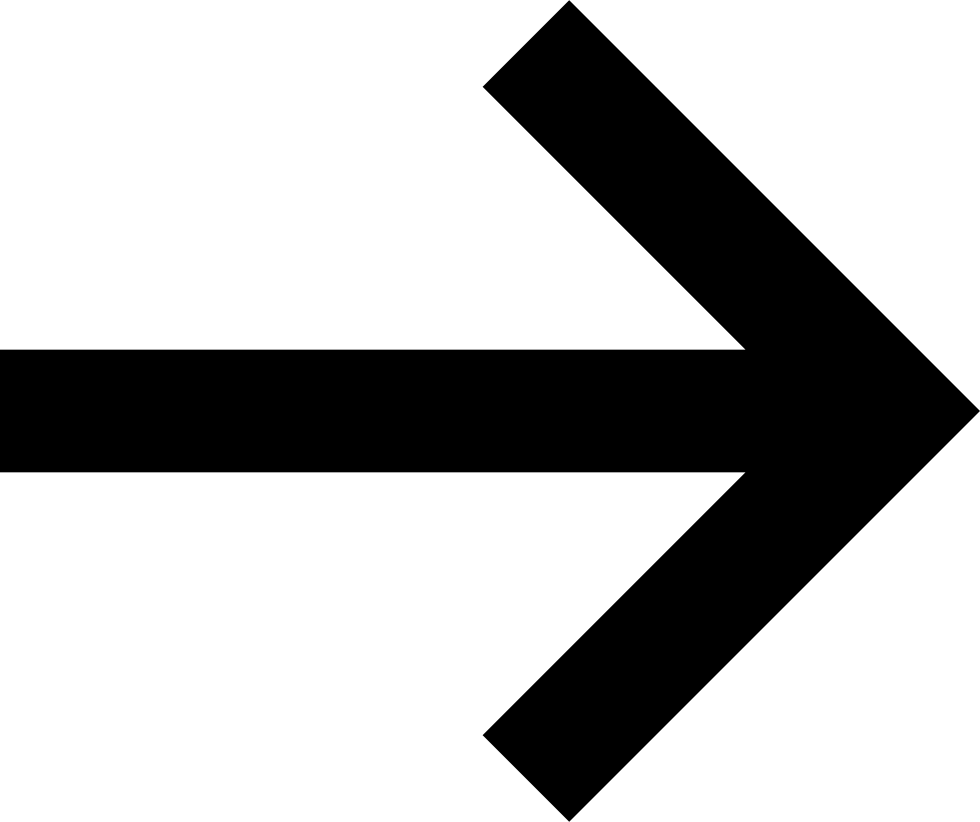
 Lista dei doppiatori italiani della serie di Cuphead
Lista dei doppiatori italiani della serie di Cuphead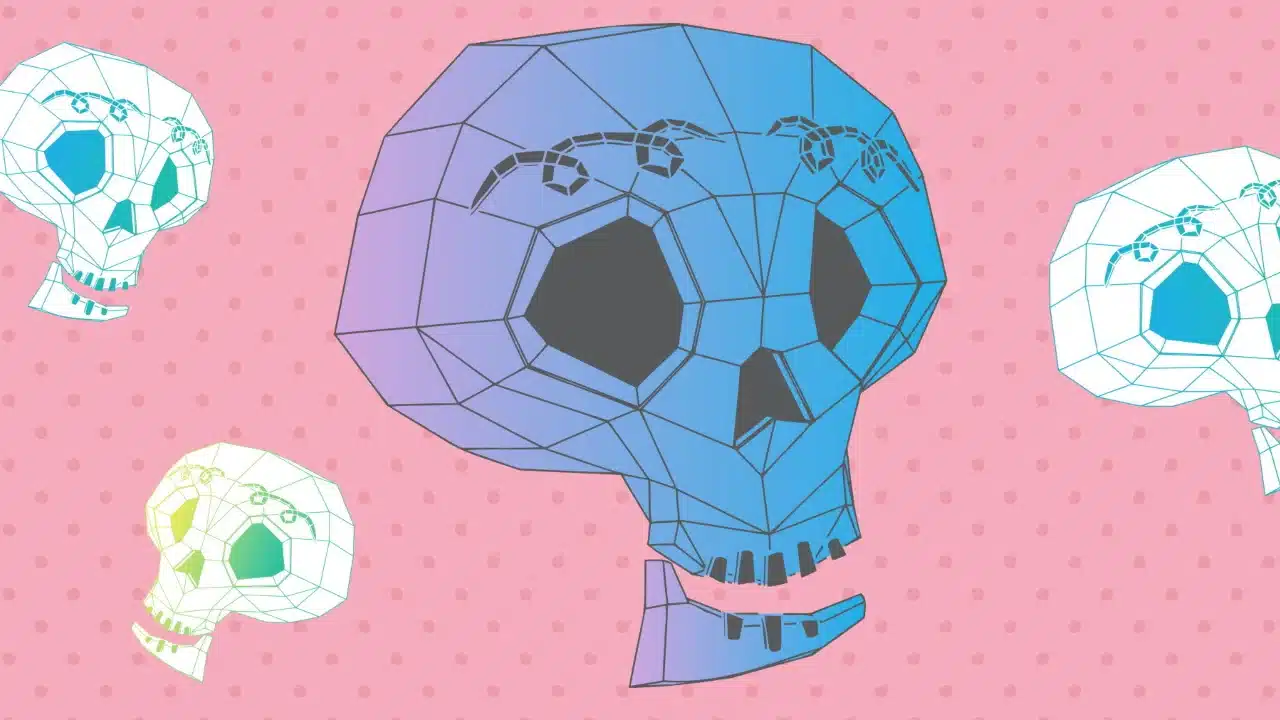 Day of the Devs: tutti gli annunci dello showcase dei giochi indie
Day of the Devs: tutti gli annunci dello showcase dei giochi indie Intervista a Stefano Brusa: doppiatore di Cuphead
Intervista a Stefano Brusa: doppiatore di Cuphead